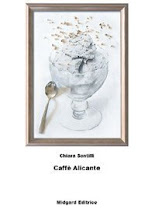Non molti secoli fa, l’uomo inventò un oggetto chiamato Walkman.
Questa scatoletta di plastica – pressoché sconosciuta alle nuove generazioni – ha di fatto rivoluzionato il modo di ascoltare la musica, offrendo alle persone la possibilità di portarla con sé ovunque e diventando una vera e propria icona degli anni ottanta.
Anch’io ne avevo uno, precisamente un Philips nero con righe sottili in rilievo e tasti grigi. Le cuffie, invece, erano di gomma morbida, larghe e spesse, tenute insieme da un archetto metallico (non rivestito) che mi graffiava la fronte ogni volta che lo mettevo in testa, puntualmente.
La praticità e l’estetica, insomma, lasciavano un po’ a desiderare e andare in giro con quell’attrezzatura vistosa e intrecciata di fili, rendeva la somiglianza con Robocop quasi immediata.
Nonostante tutto, credo che nessun cd o file mp3 potrà mai restituirmi l’emozione di ascoltare una musicassetta con il Walkman. Ma vuoi mettere il rumore di fondo tra un brano e l’altro, il nastro magnetico che usciva matematicamente dalle bobine facendo perdere la pazienza anche a un santo, il lato A e lato B da venti minuti al massimo e il tru-tru-tru-tru improvviso alla fine di ogni lato?
Ora che il Walkman è diventato una rarità vintage – come sempre accade per le cose vecchie scansate da quelle nuove – io posso orgogliosamente affermare di averlo avuto e utilizzato (anzi, di averne abusato!) e di averci ascoltato almeno una cinquantina di musicassette. Me ne torna in mente una, di Raf, anno 1989 (cioè ventidue anni fa, ripeto v e n t i d u e): c’era dentro un brano fantastico, uno di quelli che non ti lasciano scelta, che devi obbligatoriamente cantare a squarciagola…